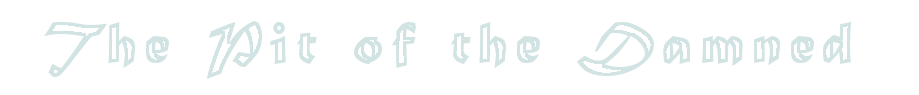|
| #PER CHI AMA: Rock Progressive |
I Sahona sono una formazione francese di matrice indie rock con richiami progressive e attitudine shred metal, in attività dal 2014. Siamo di fronte ad una classica rock band di quattro elementi e questa di cui parleremo, è la prima ed omonima pubblicazione autoprodotta. La copertina rappresenta, per assurdo, quello che le orecchie andranno a percepire, cioè un paesaggio poco definito e surreale in cui una piccola ombra antropomorfa osserva la strada che sta percorrendo, indecisa se proseguire o virare sul sentiero che si stende alla sua sinistra. Il nome della band deriva dal cognome del cantate chitarrista Charly Sahona, il principale autore e mente dell’opera. Charly è un gran musicista senza dubbio, ha perfetta padronanza della sua voce, della sua chitarra e dei suoni in generale, ma purtroppo qualcosa non torna. Sembra infatti che Charly stia guidando una Ferrari ma non abbia idea di dove stia andando. Gli altri componenti della band sono altrettanto validi tecnicamente ma ciò che manca ai Sahona non è sicuramente il saper suonare ma è la ricerca di significato, di qualcosa da trasmettere. Ma ora basta parole, inseriamo 'Sahona' nel lettore e vediamo cosa esce. All’inizio la sensazione è piacevole, c’è un forte gusto per la melodia e i suoni sono curati in maniera quasi maniacale. L'opener “Light of Day, Sense of Life” per qualche attimo mi culla e mi soddisfa, grazie a uno scenario pacifico, psichedelico ed etereo dal sapore molto Muse; anche la voce mi ricorda molto quella di Bellamy, le note sono suadenti e cantate con forte carica emotiva. Tuttavia questo paesaggio non riesce a trovare una sua giusta forma nella mente di chi ascolta perché interrotto da parti che musicalmente sembrano non avere molta attinenza con le precedenti, ogni parte ha una sua linea vocale differente e una diversa sequenza di note. L’effetto è quello di non riuscire a seguire il pezzo per le troppe informazioni proposte, l’orecchio è continuamente sorpreso da nuove idee ma allo stesso tempo spaesato in quanto non riesce a trovare il filo conduttore che guidi le sensazioni attraverso il brano. Il livello tecnico però rimane altissimo, non c’è una sbavatura e tutti i musicisti sono perfettamente amalgamati. Il disco prosegue senza troppe sorprese, tutte le tracce presentano caratteristiche simili, cioè una strofa psichedelica stile Muse, un ritornello distorto e l’immancabile assolo shred, con mille note eseguite a velocità supersonica, peraltro sempre in modo impeccabile. A parere mio questo tipo di assoli risultano fuori luogo con il sentimento delle canzoni, e purtroppo molto spesso ne rovinano l’atmosfera. Vale la pena ascoltare questo disco per imbattersi in “I’m Alive”, forse il pezzo più interessante del cd. Si tratta di una ballata con un caldo suono di pianoforte elettrico come sottofondo, la voce è sognante e malinconica e l’intreccio di strumenti crea un paesaggio onirico senza tempo. Questa song sarebbe andata in loop per un bel po’ nel mio stereo, se non fosse presente l’elemento di disturbo degli assoli; in questo disco sembra che ogni brano debba per forza contenerne uno. Da notare la gran prestazione di batteria di Stephane Cavanez che negli ultimi brani del lavoro trova la sua maggiore espressione; in generale in tutta l’opera, la precisione della ritmica è senza dubbio un punto di pregio. Alla fine, 'Sahona' è un lampante esempio di come la capacità tecnica non sempre riesca a produrre della musica che parli all’anima. Dalle note si percepisce un ego molto presente e una forte tendenza all’autocelebrazione; ma la musica deve fare bene a tutti, non solo a se stessi. In conclusione una cosa bella: sicuramente quando l’ombra in copertina si renderà conto di quale via è destinata a percorrere, la musica dei Sahona ci regalerà momenti memorabili. (Matteo Baldi)
(Self - 2016)
Voto: 55